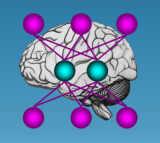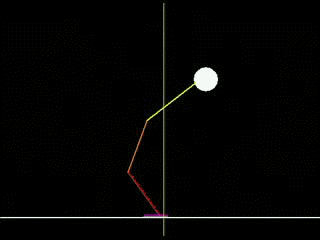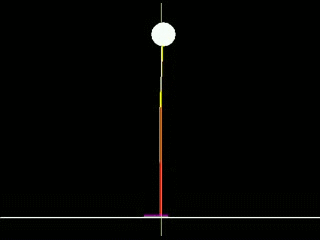POSTURA
POSTURA ERETTA: MODELLO AUTOAPPRENDENTE A RETE NEURALE
Sulla base delle esperienze effettuate con il modello di apprendimento motorio non supervisionato descritte in BRACCIO, abbiamo pensato di verificare se un’analoga rete neurale artificiale con apprendimento learning-by-doing potesse consentire ad un modello di corpo umano schematizzato, simulato su computer, di apprendere autonomamente il mantenimento della posizione eretta anche con perturbazioni del sistema.
L’apprendimento di questo compito motorio rappresenta una sfida particolare per il learning-by-doing, poiché il mantenimento della postura eretta, in particolare in un modello semplificato come questo, è quantomai inadatto al learning-by-doing in quanto qui paradossalmente l’obiettivo è non muoversi, ma mantenere una posizione più stabile possibile, ovvero “learning by…non doing”. Qui, infatti, la possibilità di apprendimento decresce progressivamente con il migliorare della capacità di mantenere la postura, per il progressivo minor numero di movimenti sperimentati.
Metodo
Rispetto al modello del braccio questa rete ha un unico compito motorio: la “volontà” si limita, infatti, a richiedere costantemente soltanto che la testa sia mantenuta più alta possibile (lo sperimentatore ha comunque la possibilità di aggiungere uno o due compiti accessori che descriveremo fra poco). Ma la fisica e il sistema sensoriale che la rete si trova a dover gestire sono ora più complessi.
Il modello bidimensionale di corpo umano utilizzato è costituito da cinque segmenti (piede-gamba-coscia-tronco-testa) articolati tramite quattro giunti (caviglia-ginocchio-bacino-collo). Ogni segmento è soggetto a forza di gravità e all’azione di muscoli (un muscolo flessore e un estensore per ogni articolazione come nel modello braccio). La fisica (simulata) complessiva del sistema, pur semplificata, prende in considerazione, oltre ai detti fattori gravitazionali e muscolari, anche l’inerzia dei segmenti, la rigidità delle articolazioni, e le forze elastiche insorgenti dalla flessione o estensione di ogni articolazione. Il movimento è limitato al piano sagittale del modello posturale.
Il sistema sensoriale, oltre alle informazioni visive e a quelle propriocettive delle articolazioni come nel modello braccio, comprende anche informazioni propriocettive dalla pianta dei piedi (posizione della proiezione verticale del baricentro sulla base di appoggio) e informazioni vestibolari sull’inclinazione assoluta della testa (direzione del vettore gravità rispetto all’asse verticale della testa) e sulla sua accelerazione.
Tutte queste informazioni sono fornite alla rete attraverso 24 unità di input. I comandi provenienti dalla “volontà” sono codificati in ulteriori 2 unità di input per la posizione della testa rispetto al mondo esterno nel solo asse Y, per un totale quindi di 26 unità di input.
Il programma consente allo sperimentatore di escludere uno o più canali sensoriali (visivo-propriocettivo-vestibolare) per valutare gli effetti sulla stabilità del sistema, e di ridurre a 4 il numero di segmenti corporei (e quindi a 3 il numero di articolazioni) unificando in un solo segmento la testa e il tronco, per verificare gli effetti di una riduzione della complessità del sistema rispetto all’apprendimento. In tal caso il numero di unità di input viene conseguentemente ridotto.
Infine il programma consente anche di aggiungere uno o due compiti motori “accessori”, nel qual caso le unità di input codificanti i comandi provenienti dalla “volontà” vengono corrispondentemente aumentate di numero.
Uno di questi compiti consiste nel far sì che la “volontà” chieda al sistema anche di mantenere la proiezione verticale del baricentro entro la base d’appoggio (lunghezza del “piede”). Questo compito è in effetti ridondante, poiché ogni scostamento del baricentro dalla base d’appoggio implica che il corpo sia inclinato, e questo a sua volta implica che la testa si trovi più in basso di quanto sarebbe se il corpo fosse eretto. Tuttavia può essere interessante verificare se il richiedere esplicitamente alla rete di “fare attenzione” a questo aspetto faciliti l’apprendimento della postura eretta nel suo complesso rispetto al lasciare il compito “implicito”. Questo compito richiede l’aggiunta di 2 unità di input per la volontà.
Un secondo compito motorio accessorio che è possibile imporre richiede al sistema anche di mantenere la testa eretta (verticale). Anche questo compito è ridondante in questo modello semplificato in cui la testa è rappresentata semplicemente da un segmento lineare, o da un cerchio il cui diametro è parte di tale segmento e la restante parte rappresenta il collo, poiché la testa si trova più alta proprio quando tale segmento è in posizione verticale. Tuttavia, avendo il segmento collo+testa la minore lunghezza fra tutti i segmenti corporei, le differenze di altezza prodotte dalla sua inclinazione sono spesso sovrastate dalle inclinazioni degli altri segmenti, e di conseguenza sono anche difficilmente o tardivamente apprese. Può quindi essere interessante verificare se obbligare la rete a “fare attenzione” a questo compito incrementi il mantenimento della posizione eretta anche per il capo, e quindi del corpo nel suo complesso. Questo compito richiede l’aggiunta di 4 unità di input per la volontà.
Le unità di output sono 8, una per ciascuno dei due muscoli antagonisti (flessore ed estensore) di ciascuna delle 4 articolazioni. Se lo sperimentatore adotta il modello semplificato a 3 articolazioni, ovviamente il numero di unità di output scende a 6.
Infine, l’ambiente non è esclusivamente “passivo” (uno spazio da esplorare) come nel modello del braccio, ma interviene attivamente a perturbare l’equilibrio del sistema con improvvise variazioni dell’inclinazione della base d’appoggio, e “spinte sul corpo” in avanti o indietro, con intervalli e intensità casuali regolabili dallo sperimentatore.
Il meccanismo di apprendimento, come quello per il braccio, è quello del “learning by doing”, in cui le configurazioni da apprendere sono fornite dai movimenti che il modello compie anche casualmente e la valutazione dell’errore è locale ad ogni unità neurale. Ribadiamo che non occorre quindi costruire preliminarmente alcun set di esempio, né è richiesto alcun supervisore esterno per il calcolo dell’errore.
Risultati
Il sistema apprende rapidamente (in circa 50-70000 movimenti) a mantenere la postura eretta e a controbilanciare efficacemente le improvvise oscillazioni della base d’appoggio, le spinte sul “corpo”. Tali perturbazioni risultano addirittura favorire l’apprendimento: le simulazioni in cui esse non sono applicate si concludono generalmente con il mantenimento di una posizione non eretta bensì accovacciata.
I due filmati che seguono mostrano le prestazioni del sistema prima e dopo l’apprendimento. La prestazione nel filmato prima dell’apprendimento appare migliore di quanto sia in realtà, poiché le cadute non vengono mostrate fino in fondo: appena il programma si accorge che il baricentro è uscito fuori dalla base d’appoggio (e quindi l’individuo cadrà), fa ripartire l’individuo da una posizione casuale ma con il baricentro entro la base d’appoggio.
Ogni nuova sessione di apprendimento raggiunge lo scopo in tempi diversi e con attitudini posturali leggermente differenti per flessione delle ginocchia, del bacino o del capo, con il risultato di riuscire a minimizzare le oscillazioni del capo ove sono posizionati i sensori vestibolari e visivi.
Tale comportamento, oltre che efficace, appare compatibile con le osservazioni delle strategie posturali reali umane.
Come è da attendersi, le varie modalità sensoriali si mostrano ridondanti: escluderne alcune non compromette l’apprendimento (seppure può rallentarlo). Le sensibilità più importanti in questo senso sono apparse essere quella relativa alla proiezione del baricentro sulla base di appoggio, e quelle relative agli angoli delle articolazioni.
Discussione e conclusioni
Il learning by doing si mostra un modello di apprendimento motorio versatile, efficace anche in simulazione di compiti motori molto diversi quali il muovere intenzionalmente un braccio o il mantenere la stazione eretta, e capace di funzionare anche con informazioni sensoriali differenti.
Come accennato all’inizio, il compito motorio qui simulato è particolarmente inadatto all’ apprendimento tramite “learning by doing”. E’ questo il motivo per cui in questo esperimento si sono rivelati particolarmente importanti gli “accidenti” capaci di perturbare l’equilibrio raggiunto dalla rete, e cioè le inclinazioni della base d’appoggio e le “spinte” sul corpo. Il ripetersi di questi accidenti garantisce infatti quella molteplicità e variabilità di movimenti che è necessaria per l’apprendimento, ma che il progressivo successo dell’apprendimento tende invece ad abolire mantenendo stabile e fermo il corpo. Se non si introducono questi accidenti, spesso il corpo finisce in una posizione non eretta in quanto, una volta raggiunta una qualsiasi posizione stabile, anche non eretta, non si producono ulteriori movimenti che facciano apprendere alla rete come portare il corpo in posizione eretta. E così, non effettuandoli, la rete non potrà apprenderli; e, non apprendendoli, non potrà effettuarli (un minimo locale, e un cane che si morde la coda). Gli accidenti ripetuti spezzano questo circolo vizioso e consentono l’apprendimento completo.
In effetti vi è motivo di pensare che, nella realtà biologica, il mantenimento della posizione eretta sia un compito motorio largamente espletato per apprendimento genetico piuttosto che per apprendimento fenotipico, e che il learning-by-doing intervenga “soltanto” a calibrare le strutture e i circuiti competenti (essenzialmente midollari e cerebellari) sugli effettori e le caratteristiche del corpo nel quale vengono a trovarsi. In più, nella realtà biologica vi sono innumerevoli occasioni di auto-perturbazioni dell’equilibrio (si pensi semplicemente agli effetti del camminare, muovere le braccia, ruotare il tronco, flettersi e muovere oggetti ecc.) che assicurano variabilità, e che invece mancano nel modello semplificato adottato in questa simulazione.
In definitiva, il fatto che una rete learning-by-doing riesca ad apprendere – pur a certe condizioni – anche un compito così antitetico rispetto ai principi del learning-by-doing, può essere considerato una notevole conferma della potenza generale di questo modello di apprendimento. Riteniamo quindi che questa architettura di rete neurale, in realtà abbastanza semplice concettualmente, in cui il feedback sensoriale costituisce l’elemento fondante, possa realmente essere un modello riduttivo di quanto l’evoluzione ha selezionato nel corso di milioni di anni.
Nella simulazione “Postura” è interessante notare che la “volontà”, differentemente che nella simulazione “Braccio”, ha un ruolo ridotto, limitandosi a porre costantemente il medesimo obiettivo. Una “volontà” di questo tipo sembra poter essere del tutto automatica e inconscia. Questo ben si correla con le considerazioni, esposte poco sopra, circa l’istintività del mantenimento della stazione eretta; e ci aiuta a inquadrare meglio il ruolo della volontà nel learning by doing, evitandoci di identificarla automaticamente con una reale volizione conscia. Il problema della coscienza e della volizione non è a livello della rete learning by doing, ma a monte di essa.
L’osservazione di queste simulazioni indica comunque che caratteristiche ambientali e meccanismi evolutivi sono condizioni necessarie e sufficienti per lo sviluppo di comportamenti motori anche evoluti. Il modello del learning-by-doing appare versatile e fecondo di applicazioni. Di conseguenza abbiamo pensato che, se questo modello è efficace nei meccanismi sensori-motori, potrebbe anche essere utilizzato per simulare e forse comprendere altre caratteristiche e comportamenti del sistema nervoso biologico, come ad esempio i comportamenti cognitivi. L’estensione del modello learning-by-doing ad un modello più generale, che abbiamo chiamato il “modello della tripletta fondamentale” (di cui il learning-by-doing fin qui descritto rappresenta un caso particolare a fini motori), è descritto nel libro Coscienza Artificiale e si è rivelato di successo anche nei modelli cognitivi.